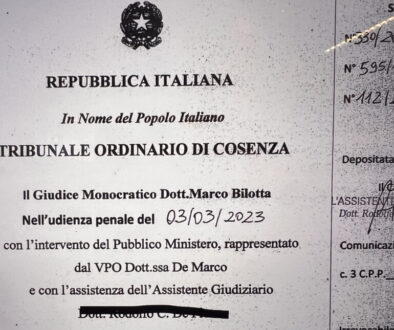#WeeklyUpdates | Funzione rieducativa della pena e sovraffollamento carcerario
“Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri” così scriveva Voltaire e da qui parte la mia riflessione.
Ci riteniamo un Paese civile, ma quanto giusti sono gli interessi culturali e i valori che animano il nostro orizzonte?
Rilevante è, a mio avviso, l’incapacità della nostra cultura giuridica, ma non solo, di fare i conti con uno dei temi più dibattuti e studiati dai giuristi: la funzione rieducativa della pena.
Bisognerebbe infatti, mutare la nostra forma mentis puntando ad una società che garantisca a chi “ha sbagliato” e se ne sia pentito di avere una seconda possibilità, costruendo una comunità che abbia la capacità di guardare al “colpevole” come soggetto che può reinserirsi nella società dopo aver pagato per quanto compiuto.
Se si vuole partire dall’analisi etimologica della parola pena, quest’ultima sottende ad una funzione esclusivamente punitiva e risulta quindi piuttosto difficile legare tale concetto a quello del rispetto dei diritti umani.
Tuttavia, il nostro ordinamento penale e le norme su cui il suo funzionamento si fonda, guarda alla dignità dell’uomo in una prospettiva di risocializzazione e crea la dicotomia tra la pena intesa come punizione e quindi la proporzione rispetto al reato, e la finalità ideologica della stessa che deve essere la rieducazione intesa come opportunità di reinserimento.
La finalità rieducativa della pena trova riconoscimento nella Carta Costituzionale che all’art. 27 che così sancisce: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Il giudice deve quindi orientare le scelte verso tale scopo ed avere riguardo alla rieducazione come fine.
Il progressivo affermarsi della detenzione come modello di sanzione penale dominante ha fatto sì che ci si concentrasse sul fine rieducativo di questo tipo di pena e quindi sul funzionamento delle carceri volto alla rieducazione, in senso lato, del detenuto. Si è colta l’opportunità, quindi, di sfruttare l’ aspetto afflittivo della pena facendolo diventare il mezzo per tendere al recupero sociale del condannato.
Spesso viene interpretata la funzione di rieducazione come risocializzazione e reinserimento del condannato e quindi come rimozione delle difficoltà che impediscono il pieno sviluppo della persona umana; tuttavia, questa visione dovrebbe allargarsi e guardare alla rieducazione come capacità di assumere le norme penali come guida per la propria condotta, mediante tecniche diverse scelte in base alla condizione sociale del reo.
In tal senso si muove la legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà”, che segnava la svolta, relativamente ai principi ispiratori della legislazione penitenziaria, e finalmente sostituiva il regolamento carcerario fascista del 1931.
Le disposizioni di tale legge , in particolare l’art.1 rubricato “Trattamento e Rieducazione” – che espressamente stabilisce: “Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi” – attribuiscono la finalità rieducativa e risocializzante della pena alla struttura carceraria.
Ciò che non permise a tale legge di di spiegare al meglio i suoi effetti, fu il particolare momento storico in cui essa venne promulgata; ciononostante, per la prima volta il carcere venne visto non più solo come luogo di isolamento e sofferenza in quanto il detenuto non doveva più solo “subire una pena” ma essere partecipe attivamente.
Le novità introdotte riguardavano infatti la riduzione degli strumenti impositivi sostituiti o affiancati da strumenti quali l’istruzione, le attività culturali, religiose e lavorative nonché la promozione dei contatti con l’esterno per il detenuto mediante i colloqui riservati con i familiari o l’utilizzo dei mezzi di informazione.
È sempre in questa prospettiva rieducativa che si sono susseguite negli anni le numerose riforme riguardanti la legge sull’ordinamento penitenziario:
– nel 1998 con la c.d. legge Simeone si cominciò a parlare di parità di trattamento ed eguaglianza come garanzia per i detenuti e si cercò di attuare la politica del “non ingresso”, valutando quei casi in cui la reclusione carceraria sarebbe risultata tutt’altro che rieducativa ma avrebbe potuto invece avere effetti de-socializzanti;
– nel 2000 venne poi introdotta la possibilità per i detenuti di accedere ai gradi dell’istruzione superiore con la creazione di una apposita figura, il mediatore culturale, nato per dare una risposta al problema della diversità di lingue e culture visto l’incremento dei detenuti stranieri;
– nel 2013 venne introdotta la possibilità per i detenuti di svolgere attività di volontariato a titolo gratuito e la possibilità di accedere alla detenzione ai domiciliari per i colpevoli di recidiva.
Se da un lato il nostro Paese vedeva moltiplicarsi gli interventi volti all’applicazione del principio di rieducazione, dall’altro vanno segnalate negli anni le diverse critiche ricevute dal nostro sistema carcerario in ambito internazionale.
Ed infatti, la situazione rilevata per il sistema italiano era definita “patologica” in quanto numerosi sembravano i problemi dei quali era afflitto il nostro sistema e che lo etichettavano come tale e lo ponevano in condizioni di non riuscire, nonostante i numerosi interventi legislativi, ad attuare il principio di rieducazione.
Al sistema carcerario italiano infatti, ad oggi si deve contestare il problema del sovraffollamento che influisce sul trattamento del detenuto ed anche sulla possibilità di reinserimento che dovrebbe essere data allo stesso.
Il carcere attualmente si dimostra inefficace nel garantire una pena che sia davvero rieducativa e questo è dimostrato dalla percentuale di recidiva registrata nel nostro Paese.
A mio avviso, più che concentrarsi sul problema del sovraffollamento come se fosse un problema quantitativo, bisognerebbe vederlo sotto un punto di vista qualitativo.
Infatti, ciò che risulta – a mio parere – errato è la mancanza di strutture apposite per gestire le condizioni dei singoli detenuti; andrebbe meglio gestita la presenza di problemi diversi alla posti a base delle condotte penalmente rilevanti.
Sarebbe necessario, ad esempio, che i soggetti tossicodipendenti possano essere trattati in maniera adeguata rispetto ad altri che hanno problematiche diverse.
Allo stesso modo è richiesto un trattamento specifico per i detenuti stranieri in quanto la figura del mediatore culturale, certamente utile, non basta a garantire il loro adeguato trattamento e a concedere che gli stessi possano reinserirsi nella società tenendo conto della loro cultura e lingua, alle quali spesso viene implicitamente richiesto di rinunciare e quindi si trovano a dover adattarsi culturalmente più che a reinserirsi.
Rieducazione, in definitiva, dovrebbe significare poter scegliere, dovrebbe significare consapevolezza e dovrebbe condurre il detenuto a migliori condizioni di vita rispetto a quelle già vissute che lo hanno guidato verso la commissione del reato.
Rieducazione uguale eguaglianza: ma riusciremo mai ad entrare in quest’ottica?
A prescindere dalla legge, credo che il cammino sia ancora lungo, ma mi candido come promotrice di un messaggio: rieduchiamoci a pensare che è necessario dare una concreta possibilità di riscatto a chi, pur avendo sbagliato, può e deve migliorarsi!
Dott.ssa Marilena Forte